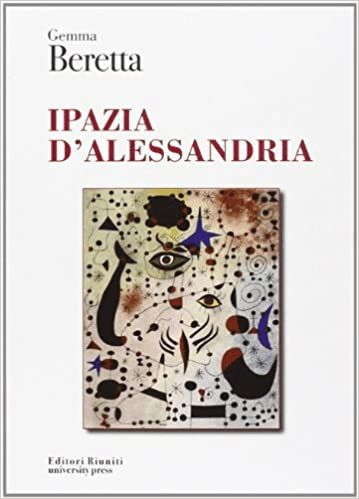
Nota di Gemma Beretta: In occasione della pubblicazione della prima edizione del libro Ipazia d’Alessandria l’energica e brillante Pia Mazziotti, allora responsabile del sistema interbibliotecario della città di Roma, organizzo una bellissima presentazione del volume con ospiti illustri quali Lidia Storoni Mazzolani e Gabriele Giannantoni. Ricordo con emozione quell’incontro al quale andai accompagnata dai miei genitori, discreti come sapevano essere ma al contempo orgogliosi e attenti, ci fu poi alla fine uno scambio tra mio padre e Giannantoni che indossavano lo stesso impermeabile color crema che inavvertitamente invertirono con successivo inseguimento. Imparai molto da questo scambio. Se non ho mai pensato di trascrivere l’intervento di Lidia Storoni Mazzolani, la cui biografia di Galla Placidia mi aveva indubbiamente ispirato nella stesura della mia ricostruzione storica della figura di Ipazia, trascrissi e studiai invece subito l’intervento di Gabriele Giannantoni che, in quanto storico della filosofia di grande acume aprì con il suo intervento una visione storico-filosofica sul pensiero di Ipazia e sulla sua collocazione nella genealogia socratico/platonica che ritengo meriti di essere rilanciata e approfondita. Ecco la trascrizione del suo intervento, purtroppo mai rivista dall’autore che non ebbi più l’occasione di rivedere né allora pensai di ricontattare tramite la mia maestra di filologia Fernanda Caizzi Decleva di cui Giannantoni era amico ed estimatore.
Mi unisco senz’altro agli elogi che sono stati fatti al libro e all’autrice, voglio attribuire qualche merito anche all’ottima scuola dell’autrice, ma in ogni caso il suo merito è evidente e, diciamo, il primo elemento che risulta dalla lettura di questo libro è la grande familiarità che l’autrice ha con vicende storiche e culturali estremamente complesse come sono quelle che vanno tra il IV e il V sec. d.C. Diciamo pure dopo la fine dell’impero di Costantino fino alle estreme propaggini dell’impero romano, nell’accezione di due imperi, quello occidentale e quello orientale.
Sono periodi convulsi, perché naturalmente l’enorme estensione dell’Impero comprende una tale molteplicità di etnie, di credenze, di orientamenti e una dualità di potere che conosce momenti più accentuati e momenti di maggiore accordo ma sempre con ripercussioni estremamente complesse in chi di questi due poteri – cioè quello imperiale e quello ecclesiastico – non faceva parte.
Il grande contrasto tra paganesimo e cristianesimo – mi pare che in questo l’autrice abbia ragione – comincia ad allontanarsi, ma emerge una realtà politica e sociale delle varie province dell’Impero estremamente complessa. E mi pare che, sempre per restare sullo sfondo storico, l’autrice abbia anche sottolineato in modo giusto l’importanza che erano venuti assumendo i vescovi di Alessandria, anzi il vescovato di Alessandria. Da Atanasio a Cirillo quelli di Alessandria sono tutti grandi vescovi che hanno un ruolo di primo piano nella definizione del dogma cristiano, basta pensare al concilio di Nicea del 325 e poi via via fino a quello della definizione del dogma di Maria. Questi vescovi, quindi, costituiscono la spina dorsale della Chiesa che ormai ha conquistato nell’Impero il ruolo predominante di religione ufficiale e questi stessi vescovi quando si manifestano residue ostilità da parte dell’Impero assumono un ruolo di un vero e proprio contropotere.
Quindi la situazione di Alessandria è in certo modo emblematica della storia dell’Impero perché ad Alessandria, per certi aspetti, le rigidezze politiche, ideologiche e teologiche sono maggiori che altrove, però nello stesso tempo ci sono sintomi di pacificazione, di allentamento delle tensioni che come sistole e diastole determinano la vita sociale, culturale di questa città. Del resto Alessandria, culturalmente, era stata la patria della rinascita del platonismo con Eudoro e poi con tutta una tradizione, quella del cosiddetto medioplatonismo che è il prologo al neoplatonismo vero e proprio. E ad Alessandria c’era stato il grande incontro tra la cultura ellenica e la cultura giudaica, prima con la traduzione della Bibbia a opera dei Settanta, poi con Filone di Alessandria. E, non a caso, anche ad Alessandria si manifestano le tendenze più spiccate del neoplatonismo cristiano: Origene e Clemente Alessandrino. Quindi questo di Alessandria era un terreno particolarmente fecondo e ricco di contrasti nel quale giustamente l’autrice colloca, e mi pare molto bene, la figura di Ipazia.
Ipazia studia matematica con il padre. Le testimonianze naturalmente sono molto scarse – Beretta le riporta tutte e mi pare occupino una decina di pagine, tutte e tre le testimonianze fondamentali, cioè Socrate, Filostorgio e Damascio, più qualche cosa di Fozio e della Suda (lasciamo liberi di ritenere se sia un titolo o se un autore), ma in ogni caso, benché poche, sono molto dense, perché ci dicono del profilo di scienziata di Ipazia e, devo dire che sono rimasto persuaso dalla dimostrazione che l’autrice fa anche del contributo scientifico dato al padre soprattutto nell’attività ecdotica, editoriale del testo di Tolemeo. Sono anche d’accordo con lei che, nel catalogo delle opere di Ipazia, il Canone astronomico è un’opera originale e non un commento a un Canone astronomico. Quindi Ipazia è una personalità! È stata già ricordata l’attività di matematica di Ipazia, ma le fonti ci parlano anche della sua attività di astronoma, quindi una personalità scientifica molto importante che si inserisce nella tradizione del Museo, e oltre a questo, Ipazia è anche filosofa. Sul contenuto della filosofia di Ipazia, le fonti non ci dicono nulla. Ci dicono solo che era conoscitrice di Platone e di Aristotele e che era in grado di insegnare meglio di chiunque altro la filosofia di Platone e Aristotele e le altre filosofie.
Tuttavia io concordo con la tesi di Garzya – che anche l’autrice riprende – di un carattere particolare del neoplatonismo alessandrino, sia nei confronti del neoplatonismo orientale, sia nei confronti del neoplatonismo ateniese. Quello orientale ormai indirizzato su una strada prevalentemente volta alla mistica, alla teurgia, all’irrazionale – diciamo così -, e quello ateniese più orientato a una polemica anticristiana.
Quindi il neoplatonismo alessandrino si caratterizzerebbe per un verso per una difesa dell’autonomia della ragione, della ricerca filosofica nei confronti di tutto quel torbido mondo mistico orientaleggiante che è proprio non tanto di Giamblico quanto del suo successore Edesio. Ma anche nei confronti dell’intransigente neoplatonismo ateniese, il neoplatonismo alessandrino si caratterizzerebbe soprattutto per una maggiore conciliazione nei confronti del cristianesimo. Però restiamo sempre un po’ ancora alla periferia della filosofia, non si capisce ancora bene quale può essere stato il contributo di Ipazia.
Allora io, accogliendo – e su questo vorrei sentire poi anche l’opinione dell’autrice -, raccogliendo proprio le indicazioni che sono date dall’autrice, vorrei fare due considerazioni. La prima è questa: Sinesio, discepolo fervente, ammiratore devoto di Ipazia, in qualche modo pone il suo rapporto con la maestra nello stesso rapporto in cui pone il rapporto di Socrate con Aspasia. Aspasia non è proprio una filosofa, è caso mai una politica, ma indubbiamente qui sarebbe anche da approfondire la tradizione dei dialoghi platonici perché l’Aspasia di cui parla Sinesio è certamente l’Aspasia del Menesseno, cioè quella che insegna a Socrate l’oratoria, in particolare l’oratoria encomiastica, però da tutta la tradizione socratica noi sappiamo che il rapporto tra Socrate e Aspasia dovette avere dei confini più ampi. E anche in altri luoghi l’autrice insiste – e mi pare giustamente – su una certa analogia tra Ipazia e Socrate. C’è un punto che a me è parso particolarmente felice ed è quando l’autrice attribuisce all’insegnamento di Ipazia, quella concezione della filosofia che noi possiamo riscontrare direttamente sui testi di Sinesio e di Socrate Scolastico, la quale si riconosceva non soltanto nella tradizione platonica – e quando parliamo di tradizione platonica dobbiamo intendere la tradizione medioplatonica e neoplatonica – ma anche nella tradizione scettica, ed entrambe le faceva risalire a Socrate.
E questa mi pare una felice intuizione che l’autrice espone alle pagine 121 e 123, proprio perché l’elemento dell’aporia, del dubbio, non è soltanto intrinseco alla figura di Socrate, ma è una tendenza che, come un fiume carsico, ogni tanto riappare anche all’interno della stessa tradizione platonica. E quindi questo mi pare senz’altro plausibile, giusto. Poi c’è un altro elemento, ed è quello del cinismo di Ipazia. Mi pare, se ho capito bene, che la Beretta non sia tanto d’accordo con questa interpretazione cinica, e indubbiamente né la parresia di Ipazia, né il suo mantello né il suo girare per le strade possono essere assimilati a quelli dei cinici. Però, se noi usciamo dal folklore – dal folklore cinico, intendo dire – e andiamo al nocciolo del cinismo, forse queste analogie sono meno peregrine di quanto possa sembrare. Voglio dire che l’atteggiamento cinico è fondamentalmente un atteggiamento di antagonismo con le istituzioni, con la civiltà e con la cultura predominanti. Il ritorno alla natura predicato dal cinismo ha questo senso: contrapporre un altro mondo di valori e un’altra visione del mondo a quelli che la civiltà e la storia hanno costruito, per così dire, sulle spalle degli uomini, hanno cioè imposto agli uomini. Ora questo atteggiamento antitetico rispetto alla cultura, alla civiltà e alle istituzioni esistenti, c’è indubbiamente anche in Ipazia. E Beretta certamente ricorda questi vari momenti.
Facciamo qualche esempio. L’esempio intanto più clamoroso è il dualismo tra autorità e potere. Ipazia diventa una figura simbolica del mondo dei valori femminili proprio perché si pone in antitesi al mondo costituito dei valori maschili. Ora questa antitesi in che cosa consiste? Certamente dal punto di vista culturale già nel fatto che Ipazia abbia studiato, perché non era un fatto comune, tanto più sottolineato dal fatto che riesca a raggiungere risultati particolarmente apprezzabili. Quindi c’è un’antitesi in primo luogo sul piano culturale: il mondo della cultura, riservato agli uomini, viene invaso da questa figura femminile che impone la sua autonomia in questo campo. Poi sul piano politico perché appunto Ipazia, pur non avendo nessuna carica, pur non potendo accedere a nessuna magistratura, tuttavia diventa il punto di riferimento politico, a tal punto che Cirillo può prendere come pretesto il fatto che lei frequentava il Prefetto augustale per poter dire che era lei che non voleva la conciliazione tra cristiani e pagani. E anche questo punto è ricostruito, mi pare, molto bene.
Ma c’è anche l’elemento, come dire, della provocazione che è tipica del cinismo e c’è l’episodio emblematico su cui, giustamente, l’autrice insiste varie volte nel libro che è quello con cui Ipazia fronteggia la passione del suo discepolo innamorato. Che è un gesto senza dubbio provocatorio, ma è provocatorio perché porta a una trasmutazione dei valori nel senso che ciò che era considerato sozzura, contaminazione, elemento di inferiorità – cioè il mestruo -, diventa invece l’elemento della purificazione e della salvezza di quel giovane. Ora non dirò che questo sia un aspetto dell’anadeia, cioé della sfrontatezza cinica, però certamente è un gesto simbolico che deve servire a ribaltare un mondo di valori che si era consolidato.
Quindi ritengo che questa analogia con i cinici sia certamente da sbrigare in poche parole se rimaniamo nel folklore cinico, ma se, invece, per cinismo si intende il recupero di un ellenismo, reinterpretato lungo la tradizione platonica, che si contrappone al mondo dei valori che l’Impero romano e la Chiesa cristiana avevano costituito, allora non dico che Ipazia sia mai stata cinica, ma una certa analogia tra la funzione dei cinici e la funzione di Ipazia, forse, in questo senso, si può marcare più di quanto solitamente non sia stato fatto.
Anche quello che si dice sull’insegnamento di Ipazia e cioè che in parte l’avrebbe fatto dentro casa e in parte sulla strada a disposizione di tutti, anche questo è un elemento socratico di Ipazia: in un momento in cui tutta la cultura era fortemente istituzionalizzata, soprattutto uscire per le strade a insegnare a chiunque volesse era un fatto di rottura.
Il rimpianto che rimane è che vorremmo sapere di più del contenuto di questo insegnamento, perché nella storiografia moderna il neoplatonismo alessandrino è un po’ liquidato come un neoplatonismo erudito in cui prevale nettamente il commento ai testi di Platone e di Aristotele più che opere originali – questo certo è una tendenza di tutto il platonismo post plotiniano – però al platonismo alessandrino non sono riconosciuti grandi caratteri di originalità. Forse questo è soltanto qualche cosa che dipende più dallo stato delle fonti o dall’occhio con cui sono state guardate le fonti che dalla realtà. E assumere un occhio diverso, come la Beretta dice, è istruttivo per vedere quello che generazioni di storici non hanno visto e che invece può essere visto. Quindi mi rallegro con Beretta: ho imparato molto dalla lettura del suo libro.